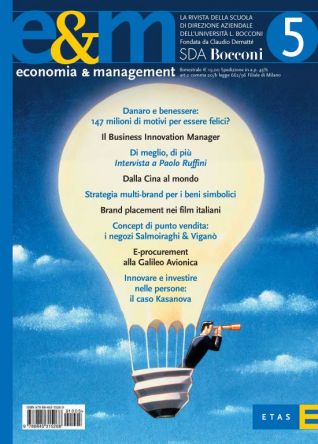E&M
2009/5
Il fascino discreto della borghesia
Il nuovo film di Luca Guadagnino, Io sono l’amore, mette in scena una grande famiglia imprenditoriale milanese alle prese con il problema della successione e del passaggio generazionale. Ne emerge una rappresentazione della borghesia contemporanea forse discutibile ma di indubbio interesse sociale e culturale.
Io sono l’amore
Regia: Luca Guadagnino
Interpreti: Tilda Swinton, Pippo Delbono
Italia, 2009
La neve, il freddo, il gelo. Si apre così Io sono l’amore di Luca Guadagnino: con visioni dall’alto e di sghembo di una Milano innevata come non la si era mai vista sugli schermi, immersa in una luce raggelata e malinconica che si riverbera monocroma dal bianco ingrigito della neve per le strade al grigio più cupo delle facciate dei palazzi e dei tetti delle case. Tutto il film, anche quando cambia spazi, luci e luoghi, si porta addosso il gelo e il grigio del suo incipit, quasi a sottolineare l’operazione di raffreddamento che Luca Guadagnino e i suoi collaboratori operano sul corpo incandescente del genere più caldo della storia del cinema, il mélo.
Io sono l’amore sembra infatti una storia alla Visconti – un po’ Gruppo di famiglia in un interno, un po’ Vaghe stelle dell’Orsa, un po’ La caduta degli dei – girata con la freddezza e il distacco di Antonioni: quanto più l’intreccio si fa caldo, e offre spunti e possibilità melodrammatiche, tanto più la regia frena, raffredda, distanzia. E ciò è tanto più interessante quanto più Io sono l’amore è, di fatto, un film sulla borghesia imprenditoriale milanese. Non sulla nuova borghesia fatta di arricchiti e parvenus, spesso volgari e inconsapevoli di sé fino al grottesco involontario, ma su quel ceto dirigente che ha fatto dell’eleganza e della concretezza i suoi segni distintivi, anche se spesso ha faticato a trasformare il proprio primato economico in capacità concreta di governo della società. Anche i Recchi, la dinasty al centro del film, celebrano i loro riti sociali e familiari chiusi nel silenzio ovattato di una delle più belle ville storiche di Milano, fra arredi di protodesign firmati dall’architetto Portaluppi, pavimenti in legno e discorsi pronunciati quasi sempre a bassa voce. È la discrezione, feticcio storico dei riti di autorappresentazione della borghesia ambrosiana, a dominare anche la messinscena di Luca Guadagnino. Ma è un feticcio destinato a implodere in se stesso quando la famiglia protagonista si trova a dover fare i conti con uno dei nodi storici di ogni grande famiglia imprenditoriale: il passaggio generazionale. Ed è proprio su questo terreno che il film offre più di uno spunto di riflessione – problematico e talora anche provocatorio – sui modi e sulle forme con cui la borghesia italiana affronta un problema cruciale come la successione. Ne discutono, come di consueto, Severino Salvemini e Gianni Canova.
S.S. Devo confessare che io ho trovato il film un po’ schematico. In certi passaggi forse anche un poco stereotipato. Per come rappresenta la borghesia. Per come mette in scena i rapporti e le relazioni fra i membri della famiglia. E, soprattutto, per come affronta il tema centrale della successione. Tancredi, il padre, interpretato peraltro da un grandissimo Pippo Delbono, ha tre figli: Betta, Edoardo e Gianluca. Quando si tratta di affrontare la questione del passaggio generazionale, la figlia non viene neppure presa in considerazione. E tra i due figli maschi viene scelto quello che sembra meno orientato a sentimenti ed emozioni. Non Edoardo, insomma, che ha una cultura umanistica e manifesta qualche dubbio sulla natura e la funzione del ruolo imprenditoriale, ma Gianluca, che pare più disposto ad assumere il ruolo senza interrogarsi più di tanto sulle sue implicazioni sociali e morali. Mi sembra una visione discutibile, peraltro senza riscontri nella realtà: se osserviamo attentamente anche solo la borghesia ambrosiana, mi pare di poter dire che le cose vanno ormai in maniera diversa…
G.C. Io credo che bisogna sempre tener conto del fatto che il film di Guadagnino ha un sistema di riferimenti cinefilo e culturale prima ancora che realistico e sociale. Più che radicarsi nella realtà, il film evoca, per esempio, Teorema di Pasolini, dove pure una famiglia imprenditoriale lombarda veniva sconvolta dall’arrivo di un estraneo – l’Altro – che metteva in crisi ruoli e relazioni. In Io sono l’amore accade una cosa analoga: la conoscenza di un giovane che viene da un altro ambiente sociale – un cuoco, che eccelle nella creatività gastronomica – fa saltare i meccanismi relazionali all’interno della famiglia e mette in crisi i comportamenti di alcuni dei suoi membri, a cominciare dalla moglie e dal figlio Edoardo, quello che definivi l’“umanista”…
S.S. Ciò non toglie che una narrazione che distingue fra i comportamenti ineccepibili “di facciata” e il torbido nascosto sotto il tappeto del salotto continua a sembrarmi vecchia e ormai superata. Da un lato l’etichetta, l’eleganza, il galateo, dall’altro le perversioni nascoste, i tradimenti, le ossessioni segrete. E il solito vecchio schema: vizi privati e pubbliche virtù. Funzionava nel secolo scorso, oggi mi pare che funzioni meno. Ma continuare a riproporlo mi sembra che sveli tutto l’impaccio e il disagio del nostro cinema quando si tratta di mettere in scena, appunto, la borghesia.
G.C. C’è del vero nelle tue osservazioni. E tuttavia io insisto: a me pare che il film metta a fuoco soprattutto la difficoltà della borghesia italiana a reggere il rapporto e il confronto con l’Altro da sé. La moglie di origine russa, interpretata da una superba Tilda Swinton, non viene mai davvero integrata nella famiglia. Lo stesso accade per la moglie di Edoardo, tollerata ma mai accettata fino in fondo. Come dire: o hai il nostro stesso sangue, o per noi non esisti. Sei qui, mangi al nostro tavolo, ti siedi nei nostri salotti, ma non sei davvero dei nostri. È una diagnosi severa, forse perfino troppo feroce, ma ci ricorda la storica difficoltà della borghesia italiana a integrare il diverso, a dinamizzarsi con l’innesto di forze nuove. Forse, potremmo leggere Io sono l’amore come un disincantato check-up del conservatorismo cronico di certa nostra borghesia imprenditoriale. Non di tutta la borghesia, è evidente, ma di quella parte di essa che più fatica a cambiare e ad accettare il nuovo e il diverso…
S.S. Ripeto: è un quadro novecentesco, non contemporaneo. Mi viene in mente il caso di Panza di Biumo, discepolo di una grande famiglia imprenditoriale. Quando la famiglia si accorge che i suoi interessi vanno verso l’arte e la cultura, lo spinge a fare il collezionista e a stare lontano dal business. Ma succede, appunto, nel secolo scorso. Oggi, in un’economia sempre più dominata dal simbolico e dall’emozionale, anche uno come lui potrebbe essere candidato alla successione imprenditoriale: non è più detto che sensibilità ed estetica siano inconciliabili con la managerialità. Semmai è vero il contrario. Io sono l’amore, non dimentichiamolo, comincia con la sconfitta di Edoardo in una competizione sportiva. La famiglia aristocratica non contempla neppure la possibilità che uno dei suoi membri “perda”, mentre Edoardo – vicino ai valori del merito e della competizione – accetta di buon grado la sconfitta. Secondo me, anche per questo oggi uno come lui sarebbe il candidato ideale alla successione imprenditoriale.