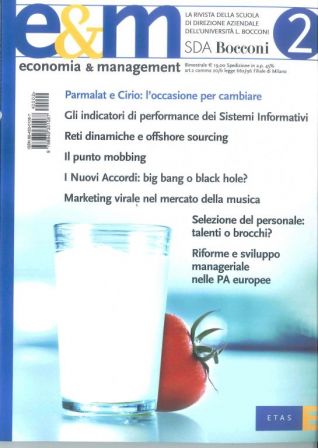E&M
2004/2
A qualcuno piace il mobbing?
Un nuovo film italiano (Mi piace lavorare di Francesca Comencini) affronta un tema delicato nella vita delle aziende e delle organizzazioni come quello del mobbing. Ma lo fa in modo molto ideologico, senza riuscire a evitare pregiudizi e luoghi comuni.
Mi piace lavorare
Regia Francesca Comencini
Interpreti Nicoletta Braschi, Camille Dugay Comencini
Italia, 2004
Anna (Nicoletta Braschi) lavora come segretaria di terzo livello in una grande azienda. È un’impiegata come tante, forse – almeno all’inizio – solo un po’ più esuberante delle altre, un po’ troppo contenta e soddisfatta del proprio lavoro. I suoi problemi iniziano quando l’azienda intraprende un processo di fusione che implica un cambio ai vertici e l’arrivo di un nuovo responsabile delle “risorse umane”: senza apparente motivo, Anna comincia a subire un processo di progressivo “declassamento” che le impone di svolgere via via mansioni sempre meno qualificate e sempre più ripetitive. Privata della sua scrivania e del suo computer, prima è obbligata a occuparsi non più delle relazioni esterne con i fornitori ma dell’archiviazione di vecchie fatture; poi viene spostata a un incarico ancor più “delicato” – così lo definisce il direttore del personale – come la gestione della macchina fotocopiatrice. Praticamente, le si impone di non fare assolutamente nulla: così, ogni giorno, Anna entra in azienda, timbra la sua scheda elettronica, si siede su uno sgabello in un lungo corridoio bianco, accanto a una macchina delle fotocopie che quasi nessuno usa, e si appisola attendendo che venga sera, scrutata impassibilmente dall’occhio della videocamera a circuito chiuso che spia e registra tutto quello che accade nei locali dell’azienda. Il nuovo film di Francesca Comencini Mi piace lavorare mette in scena un tema generalmente poco trattato dal cinema: quel processo di declassamento improvviso, di marginalizzazione repentina e immotivata che in genere viene definito mobbing. Ne discutono, come di consueto, Severino Salvemini e Gianni Canova.
S.S. Mobbing è un termine che viene dall’etologia. Originariamente è stato usato da Konrad Lorenz per indicare il comportamento di alcuni animali della stessa specie che si coalizzano contro un membro del gruppo, lo attaccano e lo escludono dalla comunità, portandolo talvolta alla morte. Nelle organizzazioni aziendali accade talora un processo analogo: si lascia intendere a un dipendente che fa sempre parte dell’organico, ma gli si sottraggono progressivamente contenuti professionali.
G.C. Ma chi è, in genere, il soggetto “attivo” di questa strategia? Chi prende la decisione di marginalizzare progressivamente uno dei membri del gruppo? Nel film non si capisce bene se si tratta di una decisione gerarchica cui tutti i membri dell’organizzazione si conformano o se è un processo collettivo che parte – come dire – quasi in maniera spontanea…
S.S. Nel film ciò non è chiaro. Esso affronta un tema importante e spinoso, ma lo fa in un modo che a me pare un po’ troppo didascalico. Senza peraltro riuscire a illuminare bene la genesi e le motivazioni del processo. In genere, il mobbing non nasce mai da un’imposizione gerarchica. È piuttosto un fenomeno tipico delle organizzazioni molto compatte, o dei gruppi sociali molto coesi: quelli che si riconoscono in una serie di valori condivisi, o in stili di vita comuni. A un certo punto può capitare che avvertano come estraneo un membro che fino ad allora aveva fatto parte del gruppo in modo organico. Non hanno il coraggio di emarginarlo esplicitamente e allora lo allontanano da sé a poco a poco ricorrendo a mezzi più subdoli e dissimulati che danno vita – appunto – al fenomeno del mobbing.
G.C. Questo meccanismo, però, il film lo illustra abbastanza bene. È impressionante il vuoto in cui la protagonista viene isolata da colleghi e compagni di lavoro. A poco a poco, nessuno la invita più a prendere il caffè, nessuno si siede al suo fianco in mensa, nessuno le presta il computer quando il suo si rompe. Certo: nessuno è sgarbato o offensivo con lei, ma tutti – semplicemente – la ignorano. Come se non ci fosse. Come se fosse invisibile. Come se fosse appestata o contagiosa.
S.S. Certo. Anche se non si spiega perché ciò accada. L’impiegata interpretata da Nicoletta Braschi è, in fondo, una persona mite. Non dà fastidio. Non è “pesante” nei comportamenti. Forse non è sufficientemente negoziale, forse è fin troppo mansueta, ma ciò non è sufficiente a giustificare – tanto dal punto di vista psicologico quanto da quello organizzativo – il mobbing che la colpisce. All’improvviso tutti provano una tale repulsione nei suoi confronti che le fanno terra bruciata intorno. Il mobbing, però, nella realtà è fenomeno complesso e delicato. E così è solo dovuto a una congenita malvagità o crudeltà dell’organizzazione.
G.C. Il tutto, però, accade mentre l’azienda sta intraprendendo un difficile processo di fusione. Non trovi che questo sia un indizio sufficientemente importante per spiegare certi comportamenti sia della direzione sia dei vari dipendenti?
S.S. Questo probabilmente è l’aspetto più interessante del film. Se non altro perché coglie potenzialmente un punto di crisi reale: quando un’azienda è impegnata in una fase di ristrutturazione abbastanza delicata e non prevede di coinvolgere un grande “tagliatore di teste”, può verificarsi comunque la necessità di ricollocare alcuni dipendenti in ambiti diversi o perfino di eliminare parte del personale. Se l’organizzazione è in difficoltà nell’individuare le persone da “tagliare”, una possibile soluzione può essere quella di fare in modo che siano i singoli dipendenti ad autoemarginarsi. Si lascia, cioè, che sia l’autorganizzazione a risolvere il problema, portando certi lavoratori a percepire se stessi e le mansioni che svolgono sotto il segno di un’assoluta e inevitabile superfluità e inutilità.
G.C. Da questo punto di vista, il film della Comencini sottolinea più la debolezza del lavoratore – nella fattispecie dell’impiegata interpretata da Nicoletta Braschi – che non la forza o l’astuzia della struttura aziendale…
S.S. Sì, anche se questo aspetto viene trattato in modo un po’ “ideologico” e pregiudiziale. Il film lascia intendere che la struttura è portata a eliminare i più deboli. Non i più lavativi, non i meno funzionali alle necessità organizzative, ma coloro che hanno minori capacità di contrastare una decisione di outplacement. E ciò non risponde necessariamente alle dinamiche reali che invece si realizzano nelle aziende. Anche l’assoluta mancanza di solidarietà nei confronti della dipendente emarginata mi sembra – in quel contesto – poco credibile: in genere, quando si tratta di mansioni scarsamente professionalizzate, dove non scattano meccanismi di competizione interindividuali, la solidarietà c’è, ed è molto forte, soprattutto tra la popolazione femminile…
G.C. Stai dicendo che il film ti sembra complessivamente poco rappresentativo di quelle che sono le reali dinamiche di mobbing all’interno delle aziende e delle organizzazioni contemporanee?
S.S. La pellicola illustra solo una faccia del problema, la parte più intuitiva. E dimostra come buona parte del cinema e della cultura italiana siano un po’ tardivi nella loro capacità di raccontare e visualizzare le dinamiche reali che oggi caratterizzano la vita delle organizzazioni. Qui si racconta ancora per stereotipi, si immagina che i controlli di magazzino avvengano tuttora con metodi fordisti, si lascia intendere che i licenziamenti vengano comunicati con cinica freddezza da direttori del personale di incredibile rozzezza, e capaci di usare frasi del tipo: “Lei non è adatta a questa azienda, lei è inadeguata…”!
G.C. Ritieni che sia un limite di questo film o pensi che questo film riveli un ritardo più generale nella percezione e nella rappresentazione dei meccanismi reali che presiedono oggi al funzionamento delle organizzazioni?
S.S. Mi auguro sia vera soprattutto la prima ipotesi. Di recente, proprio su queste pagine, abbiamo discusso di un altro film italiano – Il posto dell’anima di Riccardo Milani – che era molto più raffinato nel cogliere ciò che effettivamente sta cambiando nel mondo del lavoro, anche dal punto di vista del lavoro operaio.