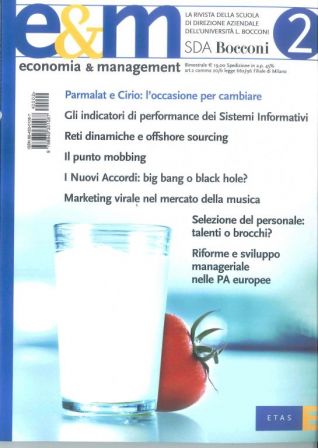E&M
2004/2
Parmalat e Cirio: l’occasione per cambiare
Scarica articolo in PDFCi risiamo, ancora una volta, purtroppo, a dovere ragionare di patologia. Il crollo di Cirio, di Parmalat, di Giacomelli, ma anche i gravi problemi di altre aziende quotate, come Arquati, Gandalf, Opengate e le perdite che ne sono scaturite ci obbligano a riflettere su molti aspetti del nostro sistema normativo, economico e finanziario. E ci obbliga a riesaminare i modelli di gestione e di governance con i quali vengono guidate le nostre aziende.
La riflessione è obbligata perché i danni prodotti dagli esiti di queste vicende gravano non solo sugli azionisti, sugli obbligazionisti, sui creditori, sulle banche e sui dipendenti di queste imprese, ma su tutto il nostro apparato produttivo, anche su quello sano: rende gli investitori italiani ed esteri più riluttanti a fornire capitale a titolo di credito e di rischio, può indurre le banche a diventare più discriminanti del dovuto, innalzerà il costo del capitale. Senza contare che le perdite subite dai risparmiatori si tradurranno in una compressione dei consumi in un momento nel quale ci sarebbe bisogno di una spinta per agganciare la ripresa internazionale. I danni, al di là della perdita diretta dei risparmiatori detentori di titoli delle aziende in questione, sono stati calcolati dall’Osservatorio ref (www.refirs.it). Il premio al rischio (per investire in azioni, anziché nei titoli di Stato) – mentre negli altri paesi dell’area euro nei due ultimi trimestri 2003 è sceso da 3,3 punti percentuali a 2,9 – in Italia è salito da 3 punti a 3,4, con due conseguenze: 1. maggior costo nella raccolta del capitale di rischio per tutte le imprese e, in aggiunta, una distruzione di 100 miliardi di euro di valore azionario, per la flessione dei valori delle azioni in seguito all’incremento del premio al rischio. Non è stato calcolato l’impatto sui consumi dell’effetto distruzione di ricchezza (quella perduta definitivamente per l’azzerarsi del valore delle azioni e delle obbligazioni e quella del deprezzamento di tutte le azioni): ma è facile che sia dell’ordine dei 20 milioni di euro.
Ma c’è anche un rischio più grave: che il “furore popolare” di fronte a questi fatti induca i legislatori e l’esecutivo a dare una risposta normativa d’impulso, populista e di tipo regressivo, tale da arrestare o perfino invertire l’evoluzione verso un sistema finanziario che s’appoggi sul mercato oltre che sul sistema bancario, come potrebbe succedere se venissero approvate norme inibenti l’emissione di obbligazioni corporate o se prevalesse la tentazione di risolvere i problemi scaricando sulle banche e le imprese regolamentazioni asfissianti.
Di fronte alle vicende in questione dobbiamo porci varie domande. Dobbiamo anzitutto chiederci se la serie di crisi che ha colpito molte nostre imprese, per fortuna non tutte con gli esiti estremi di Parmalat o Cirio, sia solo la conseguenza della stagnazione degli ultimi tre anni o se sia lo specchio di un problema più profondo, il sintomo di una transizione più radicale. Per le imprese finite in stato fallimentare, dobbiamo domandarci se ciò è accaduto per “incidente di gestione” o per cambiamenti imprevedibili non imputabili a responsabilità gestionali, oppure se è stato la conseguenza di cattivi modelli di gestione e di inadeguati modelli di governance, o, peggio ancora, di comportamenti disinvolti di espropriazione delle risorse aziendali o di vera e propria truffa organizzata. Infine, dobbiamo domandarci cosa si possa e si debba fare affinché vengano separate le mele marce e vengano corretti i comportamenti inadeguati.
Spiace, ma forse è di qualche utilità, riportare quanto ho scritto poco dopo le crisi che avevano colpito il sistema statunitense, in particolare dopo il fallimento Enron. Nella prefazione a un libro sul tema[1] scrissi nel 2002: “Anche se qualche osservatore (italiano) attento ha cercato di avvalersi di quanto è successo negli Stati Uniti per riflettere sui nostri problemi, la maggior parte dei commenti ha interpretato le vicende americane come qualche cosa che non ci tocca; anzi, quasi con sollievo, pensando ai mali altrui, essendone fuori”. Ritenevo allora, e purtroppo trovo conferma oggi, che quei problemi fossero anche nostri, a dispetto del fatto che molti considerassero il nostro tipo di capitalismo (di tipo familiare e bancocentrico) esente da patologie che sembrano invece proprie di un capitalismo di matrice manageriale, ad azionariato diffuso, con largo uso degli strumenti di finanziamento propri dei mercati finanziari.
Nella prefazione di quel libro – con riflessioni poi approfondite nel successivo editoriale su questa rivista (n. 2, 2002) – avevo sviluppato alcuni spunti che si rivelano utili oggi per ritornare sul tema. Nella prefazione, per esempio, scrivevo: “Il libro che qui viene proposto è un contributo importante perché fa giustizia delle interpretazioni superficiali e anche del fatto di credere che questo non sia un problema che ci riguarda. L’ascesa e il successivo crollo di Enron non sono solo il frutto casuale di un sistema – quello capitalistico o di mercato, che dir si voglia – che nella sua stessa natura prevede, come fatto normale e perfino necessario, che le imprese, così come possono avere successo, possano anche fallire: interpretazione avvalorata all’inizio dall’Amministrazione americana per voce del suo ministro delle Finanze. Non è nemmeno il semplice frutto di alcuni mascalzoni che si sono inseriti nel mondo aziendale, come può sempre accadere (si ricordino i robber barons di fine Novecento), piegando la gestione a proprio beneficio personale, con danno per i creditori e gli azionisti. Infine, non è neanche il semplice prodotto di un sistema di governance che ha dimostrato ex post qualche falla.
Il crollo della Enron è molto di più: questo libro lo dimostra. Esso è il risultato di diverse condizioni che sono andate maturando nella realtà americana – ma che in parte sono travasate per contagio in quella europea e italiana – alcune interne alle imprese, altre esterne. Enron è l’epilogo di una deriva che ha interessato anche altri aspetti e altri soggetti dell’economia e della società: da una troppo disinvolta deregolamentazione che ha liberato gli animal spirits, ma anche gli appetiti più voraci, alla (indiscriminata) liberalizzazione nel mondo della finanza, che l’ha portata a sganciarsi dall’economia reale. Ma entrano in questo quadro anche l’involuzione delle società di auditing, la cui etica professionale è stata distratta dai conflitti di interessi; il venire meno di un rigoroso controllo esterno degli analisti finanziari, anch’essi distolti dal loro ruolo (di guardiani) da interessi divergenti delle investment banks per le quali lavorano; la leggerezza con la quale il mondo accademico e la stampa anche specializzata hanno seguito vicende che contenevano – se uno le avesse esaminate con attenzione e distacco – i germi della successiva involuzione”.
Questo scrivevo all’indomani del caso Enron, avvertendo che l’Europa e l’Italia non erano immuni a questi problemi. Successivamente sono scoppiati i casi Ahold in Olanda, Marconi in Inghilterra, Adecco in Svizzera, Skandia in Svezia e i nostri due maggiori crolli, oltre a tanti altri minori per dimensione, ma non per natura e gravità dei fatti.
È venuto il momento di fare qualche altro passo nella diagnosi e nella ricerca di interventi correttivi.
Le crisi come effetto di un cambiamento “climatico” strutturale
Osservando la sequenza dei grandi fallimenti che hanno attraversato tutto il mondo occidentale sviluppato negli ultimi anni, è difficile non vedere la connessione stretta con tre processi innescati deliberatamente dai governi: la liberalizzazione interna, che ha iniettato dosi massicce di concorrenza; quella esterna, che ha dato luogo alla globalizzazione; e la privatizzazione, che ha tolto alle imprese che prima erano pubbliche la garanzia di non fallire e ha liberato energie prima sopite. Altrettanto evidente è il collegamento fra le patologie in questione e l’affermarsi di un principio di gestione come quello della massimizzazione del valore degli azionisti. Le prime tre politiche hanno cambiato le condizioni “climatiche” delle imprese sottoponendole a un’intensificazione della concorrenza nello stesso momento nel quale c’era da fronteggiare anche importanti scossoni tecnologici con investimenti spesso in beni intangibili (R&S) che hanno ingrossato poste dell’attivo (immobilizzazioni immateriali) dal valore fluttuante. Queste pressioni competitive – volute dalle autorità per stimolare maggiore efficienza e per indurre maggiore innovazione – si sono riversate sui conti economici e finanziari delle imprese, ponendo i massimi responsabili di fronte a squilibri competitivi, economici e finanziari da correggere con interventi spesso radicali sulla gestione corrente e sempre più frequentemente anche su quella strategica. Alcuni di loro hanno visto in tempo i problemi e hanno intrapreso tempestivamente i correttivi: riorganizzazioni, focalizzazione sul core business, outsourcing e delocalizzazione, riduzione dei costi, innovazione. Altri hanno creduto che si trattasse di squilibri temporanei e, anziché intervenire, si sono posti in attesa del ritorno di tempi migliori, “massaggiando” i conti per coprire i buchi.
Il tutto è accaduto in una fase storica nella quale è andato imponendosi il principio della massimizzazione del valore per gli azionisti, che in alcune realtà è calato sui responsabili della gestione come un must irrinunciabile, premiato lautamente, se realizzato, e pesantemente sanzionato nel caso contrario.
Questo complesso campo di forze ha aumentato le probabilità di crisi aziendali, ma ha anche amplificato le tentazioni dei vertici aziendali di “barare” al gioco, vuoi nel tentativo di sottrarsi alle sanzioni – o almeno di allontanarle nel tempo – vuoi nel tentativo di cogliere e amplificare i benefici variabili, strutturati nella forma di stock options o di bonus legati al valore creato per gli azionisti.
Quanto detto – assieme anche ad altri fattori – spiega l’aumento delle situazioni di crisi, ma spiega soprattutto alcuni tratti distintivi di queste patologie: il ritardo con il quale sono emersi gli stati di insolvenza; l’evaporazione dell’attivo immateriale nel passaggio dallo stato di going concern (pieno funzionamento) a quello di crisi; la grande distruzione di attivo per la riluttanza a ricorrere tempestivamente agli istituti giuridici di gestione delle crisi; la corsa a incamerare bonus, stock options o perfino a raccogliere e distrarre risorse aziendali prima che la crisi diventi ufficiale. Il tutto usando artifizi contabili per camuffare la situazione, guadagnando il tempo necessario per perpetrare i piani truffaldini, come ebbe a dire il Financial Times in un articolo sulla corporate governance il 22 gennaio 2004 (“Managers were cooking the books in an attempt to maximize the value of their stock options”).
La prima lezione è dunque la seguente: è finita un’epoca nella quale le imprese (o meglio, alcune imprese) potevano vivere in larghezza, protette da una concorrenza addomesticata, o da situazioni di monopolio, con posizioni di rendita, che consentiva loro di accomodare tutte le richieste da parte di tutti gli stakeholder, anche di quelli che non avrebbero avuto titolo alcuno (per esempio, le tangenti ai politici). Usando una metafora, si può dire che il clima è cambiato: è diventano più freddo, e solo le imprese efficienti e capaci di adattarsi velocemente hanno la speranza di sopravvivere. Le risorse disponibili sono diminuite e, per di più, la concorrenza nei mercati finanziari, per le imprese che sono obbligate a ricorrervi, le sottopone ad azionisti divenuti padroni esigenti e severi, che premiano e sanzionano con maggiore energia, secondo le circostanze.
La seconda lezione è che gli strumenti attivati per mettere in pratica la guida secondo il principio della massimizzazione del valore per gli azionisti hanno palesato i loro lati positivi (allineando gli interessi dei gestori a quelli degli azionisti), ma anche quelli degenerativi (incrementando nei responsabili della gestione la propensione al rischio, la tentazione di incassare i benefici a breve, rinviando i problemi al futuro, la disponibilità a manipolare i conti). La pressione esclusiva, eccessiva e ossessiva verso la massimizzazione del valore degli azionisti, rinforzata da sistemi aggressivi di incentivi e di sanzioni, ha prodotto due risultati deleteri: 1. la disattenzione verso gli interessi degli altri stakeholder (creditori, obbligazionisti, dipendenti); 2. uno slittamento “etico” di molti responsabili della gestione che si è tradotto in vere e proprie espropriazioni di valore, dapprima nei confronti degli stakeholder, ma poi anche degli stessi azionisti esterni, quelli privi dei poteri di gestione. L’abbandono della concezione d’impresa come comunità di più soggetti e di più interessi – da gestire preservando la loro aggregazione costruttiva – ha finito con l’innescare, in molti casi, guerre di tutti contro tutti in una corsa all’arrembaggio senza freni e senza inibizioni.
È, questa, una situazione generalizzata? No, fortunatamente no. Accanto ai casi patologici ci sono molte imprese sane, ben gestite e con forte senso etico. Ma l’area malata si è estesa.
Come hanno potuto le imprese avvitarsi in crisi irreversibili senza che nessuno se ne accorgesse?
Se è vero che i rischi di crisi sono aumentati per le ragioni illustrate, occorre porsi due domande: 1. ci sono meccanismi interni alle imprese in grado di segnalare e affrontare tempestivamente il problema? 2. ci sono adeguati dispositivi esterni che si attivano per avvistare il formarsi dello stato di crisi e per contrastarlo?
Sul primo punto – sul quale poco o nulla è stato detto – dirò più avanti. Sul secondo, allo stato attuale delle conoscenze, c’è poco da aggiungere a quel che era già emerso nel caso Enron: tutti i principali dispositivi di controllo esterno hanno fallito. Hanno fallito i revisori esterni, in alcuni casi in modo perfino inverosimile (come si fa a controllare l’esistenza della liquidità mandando al depositario un fax – per chiedere conferma – dagli uffici della società controllata?). Hanno fallito gli analisti finanziari con una prevalenza di indicazioni di buy poche settimane prima del crollo. Hanno fallito le banche di investimento, che hanno continuato a organizzare l’emissione di obbligazioni quando le imprese erano già decotte. Hanno fallito le banche commerciali non avvertendo lo stato di dissesto, nonostante le contraddizioni nei dati (somma delle obbligazioni in essere e delle esposizioni bancarie rispetto all’indebitamento iscritto a bilancio consolidato). Non si sono accorte del problema già incancrenito né la Banca d’Italia né la Consob né altre istituzioni superiori che poi hanno cavalcato l’onda populista. Ha bucato anche la stampa specializzata, che ora è scatenata nell’additare le colpe degli altri. Gli unici a uscire pressoché immuni sono i fondi comuni italiani, nei cui portafogli le azioni e obbligazioni delle due aziende incriminate erano pressoché assenti.
In breve, ha fallito quasi l’intero sistema dei controlli esterni: quello degli enti preposti a tutelare tutti i soggetti (revisori); quelli rivolti a proteggere gli interessi propri (le banche creditrici); quelli funzionali a tutelare gli interessi dei risparmiatori acquirenti diretti di titoli azionari e obbligazionari (banche di investimento, agenzie di rating, analisti, banche nella veste di consulenti nell’acquisto titoli). Hanno sbagliato anche molti risparmiatori che ora scaricano le colpe solo sugli altri, ricercando titoli le cui caratteristiche avevano comunque un connotato di rischio segnalato (bastava osservare i premi impliciti nei rendimenti offerti).
In questo fallimento collettivo vi sono gradazioni diverse di responsabilità: va da sé che chi ha minato le fondamenta del sistema truccando i conti ha la responsabilità massima. Chi aveva il dovere di controllare quei sistemi contabili e quei conti viene subito dopo, perché è su quei conti ipotizzati come correttamente revisionati che hanno lavorato tutti gli altri. In un sistema di divisione del lavoro, basta che uno non faccia adeguatamente la propria parte perché l’edificio non regga. Ma è chi lavora sulle fondamenta che condiziona tutti quelli che seguono.
L’attenzione di queste settimane è stata concentrata sul capire perché l’intero impianto di controllo esterno non ha funzionato, con uno scambio di accuse che ha scosso anche i rapporti istituzionali. Nella mia premessa al libro su Enron erano contenuti i punti cardine della diagnosi che in questi giorni sta affinandosi. Non mi soffermerò più di tanto sul tema perché gli snodi principali sono abbastanza chiari. Occorre responsabilizzare il management sulla correttezza contabile più di quanto si sia fatto fino ad ora (con la Sarbanes-Oaxley americana l’amministratore delegato firma e assume responsabilità penali su questo punto). Occorre evitare i conflitti di interessi che minano l’indipendenza di giudizio e la determinazione delle società di revisione. E occorre sorvegliare più rigorosamente sul loro operato. Si deve regolare la possibilità che le banche creditrici non possano rientrare dalle loro esposizioni problematiche collocando obbligazioni presso i propri risparmiatori. Occorre rivedere la divisione delle responsabilità fra le varie authorities in modo che non vi siano sovrapposizioni né aree scoperte, né vi siano in seno a ciascuna obiettivi confliggenti. In breve, c’è bisogno di una revisione generale dell’impianto normativo e regolamentare. Su questo punto ormai non c’è dubbio e il governo, che in passato aveva allentato le maglie (vedasi norme sul falso in bilancio), sembra deciso a muoversi nella direzione giusta. Occorre solo evitare che l’onda di ribellione porti a normative che vanno nella direzione opposta a quella di cui ci sarebbe bisogno. Per esempio, che non blocchi il riequilibrio che era in corso nelle modalità di finanziamento delle imprese, prima dipendenti esclusivamente dalle banche, verso l’uso degli strumenti di mercato (azioni, obbligazioni, cartolarizzazioni).
Ma tutto ciò non basta se, parallelamente, non si interviene anche sui meccanismi interni di governance delle imprese. Dopotutto, è all’interno dell’impresa che tutto ha inizio: la percezione delle difficoltà di mercato o sul mercato, la registrazione dei fatti economici e finanziari dal cui quadro si evince lo stato dell’impresa, le prime avvisaglie di crisi, la messa in moto delle azioni di contrasto, l’intervento tempestivo presso le procedure quando il circolo vizioso non s’arresta. Se questi meccanismi interni non funzionano e se viene consentito che il deterioramento possa essere nascosto agli occhi esterni, anche con pratiche truffaldine, gli altri soggetti preposti al controllo esterno hanno vita difficile, se non impossibile. Questo è un tema che nel dibattito delle ultime settimane è rimasto alquanto in ombra.
La governance come primo antidoto alla distruzione e distrazione di ricchezza
Se è vero che, per le ragioni indicate all’inizio, le situazioni di crisi sono destinate ad aumentare in parallelo all’intensificarsi della concorrenza interna e internazionale (si pensi a quante nostre imprese stanno per essere spiazzate dai produttori dei paesi a basso costo del lavoro, non solo nei settori labor-intensive), cosa si può e si deve fare per evitare una distruzione di ricchezza ancora maggiore di quella che in questo processo di “distruzione creativa” – per dirla alla Schumpeter – è inevitabile?
I sistemi di monitoraggio esterno sono necessari, ma sono strutturalmente tardivi e, come si è visto, ingannabili. Il primo vero presidio deve essere quello interno all’impresa. Un presidio che deve anzitutto essere in grado di cogliere tempestivamente il deteriorarsi della situazione competitiva, economica e finanziaria. Deve poi essere capace di elaborare risposte tempestive. Infine, deve gestire l’evolversi della situazione in trasparenza, affinché i vari soggetti coinvolti possano posizionarsi per tutelare i loro interessi compatibilmente con quelli degli altri.
Qui entra in campo la governance, intesa come quell’insieme di leggi, di regole e di prassi che regolano il sistema delle relazioni, distribuendo le responsabilità e i poteri, fra i vari organi della società e all’interno di essi: la direzione, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, gli azionisti, con i loro organi, e gli altri stakeholder.[2] Governance intesa sia come assetto per migliorare le scelte gestionali, sia come protezione degli investitori, sia come equilibrata assegnazione di poteri per ottimizzare il rapporto di agenzia fra investitori e manager, fra investitori interni (azionisti di maggioranza) e investitori esterni (azionisti di minoranza, obbligazionisti, banche e altri creditori), e fra tutti costoro e gli altri stakeholder. Obiettivi, questi, che si raggiungono con una pluralità di strumenti, dai contratti espliciti a quelli impliciti (le promesse soggette a sanzioni da parte del mercato anziché dell’ordine giudiziario), dal diritto societario ai codici di autoregolamentazione.
Supponendo che gli interventi sul tavolo governativo e parlamentare affrontino in modo adeguato il problema della protezione legale dei soggetti senza potere di gestione (investitori e altri stakeholder), rimane aperta la questione di come strutturare e fare funzionare i vari organi di governo interni all’impresa per fronteggiare i rischi di crisi, quelli di cattiva gestione delle crisi e quelli di gestione truffaldina. I codici, come quello suggerito per le società quotate (in Italia il codice Preda) sono sufficienti? Sono applicati nella sostanza o solo nella forma? Devono essere modificati, integrati, resi obbligatori, o cos’altro?
Le vicende Cirio e Parmalat mettono in evidenza una serie di problemi irrisolti e anche il problema di fondo sottostante all’intera questione. È stato detto che la governance riguarda la ripartizione delle responsabilità e i poteri fra i vari stakeholder e fra i diversi organi. Qual è il modello di ripartizione più appropriato per il governo delle imprese? Ed è uguale per tutte le imprese? Per usare un’analogia con le forme di governo istituzionali, è il modello della monarchia assoluta (o del despotismo) oppure quello della repubblica liberale parlamentare fondata su un equilibrato sistema di pesi e contrappesi?
Ragioni oggettive (la necessità di decisioni rapide, in condizioni di competizione accesa e frenetica) e ragioni soggettive (la configurazione caratteriale e cognitiva) degli imprenditori e dei capitani d’impresa spingono verso assetti di governance autocratici, se non autoritari, a dispetto dei tanti libri sulla leadership partecipativa. La necessità di fornire protezione agli stakeholder esterni alla gestione e i vantaggi di una forte dialettica – costruttiva ma, se necessario, anche di contrasto – per aggregare e confrontare diverse opinioni di fronte a questioni complesse fanno invece pensare che anche nelle imprese, soprattutto in quelle brain-intensive e quelle che fanno molto conto su investitori esterni, vi debbano essere adeguati sistemi di pesi e contrappesi (quello che gli anglosassoni chiamano check and balance).
Il problema al quale oggi occorre porre mano è proprio questo: verso quale modello orientarsi? Va preservata ai responsabili della gestione la piena e incontrollata libertà d’azione, salvo punire con sanzioni ex post i loro errori o le loro malversazioni? oppure è meglio controbilanciare il loro potere e dovere di gestione con pesi e contrappesi che possano prevenire gli uni e le altre? E questo solo nelle imprese che fanno ricorso al mercato del risparmio con l’emissione di azioni e obbligazioni, oppure anche nei confronti delle altre imprese, quando queste vivono con ingenti risorse raccolte dalle banche e coinvolgono fornitori e migliaia di lavoratori?
La risposta – a dispetto delle tentazioni “giustizialiste” di questi momenti – non è così ovvia. Personalmente, credo che un ben dosato sistema di pesi e contrappesi sia utile perfino in quelle attività che più di tutte richiedono velocità di intervento (l’attività militare e quelle delle forze d’ordine). Credo, inoltre, che un sistema di pesi e contrappesi possa essere utile per tutte le imprese, ma necessario quando un’impresa impiega significative risorse di terzi, oltre a quelle di chi la guida. Ma non si può nemmeno trascurare il problema che un sistema di pesi e contrappesi possa degenerare in una situazione di attrito, se non di blocco gestionale. Quindi, va progettato con molta attenzione e oliato a dovere.
Il problema diventa allora come costruire un modello di governance che, pur lasciando ai responsabili della gestione il giusto spazio decisionale e operativo, li obblighi a misurarsi con altri sulle scelte di fondo che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’impresa e gli interessi degli altri soggetti coinvolti a vario titolo (gli azionisti di minoranza, gli obbligazionisti, le banche), e a rendere conto, in trasparenza e tempestivamente, del loro operato e dei risultati delle loro scelte.
Tralasciando, in questa sede, di ragionare sull’assemblea dei soci, su quella degli obbligazionisti, sul collegio sindacale, sui quali organi sono anche necessari interventi correttivi, e tralasciando tutte le altre considerazioni sui sistemi di controllo esterno (i revisori, le Autorità, le società di rating), sui quali sta intervenendo il legislatore, occorre chiedersi come devono essere strutturati i poteri di vertice: quello del capo azienda e del consiglio di amministrazione. Di qui bisogna partire per un buon sistema di governance, perché il buono e il cattivo partono di qui.
Su questo piano vi sono due tipi di interventi: quello sulla struttura degli organi e quello sul loro funzionamento. Sul primo sono possibili interventi sia per legge sia attraverso codici di condotta (come il codice Preda): la differenziazione fra il ruolo di presidente del consiglio e l’amministratore delegato; la costituzione, in seno al consiglio, di elementi di dialettica con l’inserimento di consiglieri indipendenti (di spirito, ancor prima che per definizione oggettiva) e con l’attivazione di sottocomitati (quello di auditing, quello sulle remunerazioni del vertice, come previsto dal codice Preda); l’articolazione delle deleghe e delle responsabilità di reporting fra amministratore delegato e consiglio; la responsabilizzazione dell’amministratore delegato, con sanzioni penali, sulla correttezza dei conti (come previsto dalla americana Sarbanes-Oaxley).
È strano che nessuno abbia rilevato che nel consiglio di amministrazione della Parmalat non vi fosse né la distinzione di ruoli fra presidente e amministratore delegato, né la presenza di consiglieri indipendenti forti, né un collegio sindacale forte: in breve, che ci fosse il sistema di governance tipico di una monarchia assoluta, che può funzionare quando tutto va bene e il monarca è illuminato ma che manca di qualsiasi meccanismo per contrastare una deriva sbagliata.
L’avere una governance di qualità va tuttavia ben oltre questi interventi strutturali sulla composizione e l’articolazione degli organi, che sono gli unici punti sui quali il legislatore o l’autoregolamentazione possono intervenire. Il problema di fondo è come possano questi organi di vertice fronteggiare, da un lato, le crescenti responsabilità loro attribuite dal legislatore e, dall’altro, la gravosità e complessità dei problemi che devono essere affrontati. Ci sono, nei progetti normativi di miglioramento della governance, una contraddizione e un vuoto.
La contraddizione scaturisce dal fatto che, volendo creare un forte contrappeso e un polo dialettico, si vogliono nei consigli sempre più consiglieri competenti, ma anche indipendenti (quindi part-time), e al tempo stesso cresce in modo più che esponenziale la complessità dei problemi sui quali essi sono chiamati a intervenire. Il vuoto riguarda, invece, l’impossibilità del legislatore di intervenire su un punto che può, almeno in parte, risolvere la contraddizione: le modalità di funzionamento interno del consiglio.
In queste condizioni gli sforzi normativi rischiano di produrre molti impegni formali e poca sostanza, aumentando le frustrazioni. I consiglieri si sentiranno oberati di responsabilità che non possono assolvere. Gli amministratori delegati vivranno l’inserimento dei consiglieri indipendenti come un’imposizione onerosa e senza valore aggiunto. Coloro che si aspettano una maggiore tutela rischiano di non ottenerla, nonostante le buone intenzioni, se i consiglieri indipendenti non saranno in grado di assolvere ai loro compiti.
La soluzione di questo problema passa attraverso un difficile e delicato lavoro di progettazione, non solo della struttura dei consigli, ma anche del loro funzionamento, che deve essere svolto da chi li deve presiedere. Come recita una libro appena uscito negli Stati Uniti e in corso di traduzione, occorre fare lo stesso lavoro che si fa quando si modifica un’organizzazione: occorre chiedersi quali sono i compiti da assolvere, definire bene gli obiettivi, darsi una struttura, progettare i meccanismi di funzionamento.[3] Occorre rendere compatibile il tempo limitato che è chiesto ai consiglieri con la complessità del lavoro da svolgere. Un lavoro di riprogettazione del funzionamento del consiglio che non possono fare i legislatori. Spetta al vertice dell’organizzazione, compete al presidente del consiglio. Ma spetta anche ai consiglieri, a maggior ragione quelli indipendenti, chiederlo. Senza questo passaggio i molti obblighi formali previsti dal legislatore non si tradurranno in una migliore governance semplicemente perché l’organo chiave – il consiglio – non sarà in grado di svolgere i maggiori compiti che gli vengono assegnati.
Peter C. Fusaro, Ross M. Miller, Quello che è andato storto alla Enron, Etas, Milano 2003.
Per un inquadramento sistemico e lucido della corporate governance, si veda Valter Lazzari, “Corporate governance: principi di fondo, aspetti controversi e prospettive future”, su questa rivista, n. 3, 2001.
Colin B. Carter, Jay W. Lorsch, Back to the Drawing Board. Designing Corporate Boards for a Complex World, Harvard Business School Press, 2004. In traduzione presso Etas.