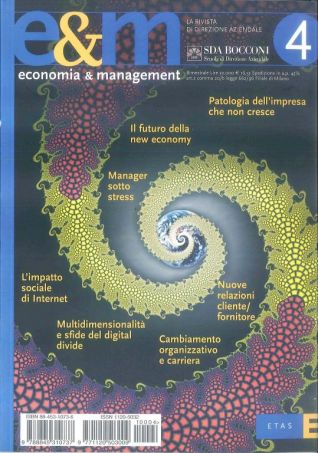E&M
2001/4
Paradossi dell'organizzazione
Un documentario sui tre grandi concerti tenutisi a Woodstock, rispettivamente nel 1969, nel ʼ94 e nel ʼ99, offre un’occasione stimolante per riflettere sulle tattiche e le strategie organizzative di una società complessa come quella dello spettacolo.
My Generation
Regia: Barbara Kopple
Interpreti: Michael Lang, i musicisti e il pubblico di Woodstock
USA, 2000
Sono passati più di trent’anni dal mitico concerto di Woodstock, eppure quell’evento continua a essere un punto di riferimento a suo modo mitico nell’immaginario di intere generazioni. Il fatto è che a Woodstock, nell’estate del 1969, non si è tenuto solo un grande happening musicale, animato (tra gli altri) da Jimi Hendrix, Janis Joplin, i Jefferson Airplane, Santana e gli Who, ma si è espresso anche – con tutte le ingenuità, gli equivoci o le illusioni dell’epoca – un grande sogno di libertà e di trasformazione che ha coinvolto moltissimi giovani di tutto il mondo. La documentarista americana Barbara Kopple (già coautrice di No Nukes con Bruce Springsteen e di Hurricane Irene con Peter Gabriel e Lou Reed) torna ora su quell’evento (e sul documentario di Michael Wadleigh che ne illustrò lo svolgimento) confrontandolo con le successive edizioni del festival organizzate dagli stessi promotori della prima manifestazione nel 1994 e nel 1999. My Generation parte dai primissimi piani dei ragazzi e delle ragazze di ieri e di oggi e dal brano di Joni Mitchell che prese il nome dal festival, poi con un montaggio serrato e avvincente mette a confronto i gusti. i sogni e i desideri di due generazioni molto lontane fra loro, eppure unite da un’analoga passione per la musica. In una continua alternanza di bianco e nero e colore, il film raggiunge il suo apice emotivo con la doppia esecuzione (nel ʼ69 e nel ʼ94) dello stesso brano di Joe Colcer (With a little Help from my Friends): quasi un malinconico omaggio al trascorrere del tempo ma anche, per fortuna, al perdurare dei sogni. Per chi ha più di quarant’anni è quasi inevitabile l’effetto nostalgia, per chi è più giovane c’è il fascino magnetico di una musica che non può non colpire al cuore.
Accanto a tutto questo, tuttavia, il film di Barbara Kopple offre anche un’approfondita e stimolante riflessione sul tema dell’organizzazione: niente di meglio che un triplice maxievento collettivo, ripetuto a distanza di anni, per valutare in modo critico e problematico come sono cambiate, dalla fine degli anni sessanta a oggi, la filosofia e la pratica organizzativa. Ne discutono, come di consueto, Severino Salvemini e Gianni Canova.
S.S. Mi ha molto colpito, nel film, la figura del manager Michael Lang. Ha organizzato l’evento “mitico” del ‘69, è riuscito a riproporlo nel ʼ94 con il pretesto del venticinquesimo anniversario e poi ha ricreato un terzo appuntamento nel ʼ99. Ha saputo fare di Woodstock una sorta di brando O di marchio. Ha saputo venderlo, tenerlo vivo e riproporlo. Mi sembra che in lui e nel suo lavoro si esprima un modo molto interessante di affrontare la “complessità” organizzativa”.
G.C. Per di più, una complessità crescente, che propone problemi diversi in ognuno dei tre differenti appuntamenti…
S.S. Certo. E la cosa interessante è che, a mano a mano che aumenta la complessità, cambia anche l’assetto organizzativo. A ogni nuova edizione del festival, Lang e il suo staff devono affrontare e risolvere difficoltà crescenti e tenere sotto controllo un numero sempre maggiore di variabili. Nel I969 sono ancora inesperti e passionali, non riescono a gestire fino in fondo l’evento che – almeno in parte – sfugge loro di mano, ma ottiene, forse proprio per questa perdita di controllo, un sostanziale consenso da parte del pubblico (che è poi, non dimentichiamolo, quello del ʼ68 ... ). È un inizio fortunato, anche se messo in piedi con talento. Con l’edizione del ʼ94 Lang e i suoi collaboratori puntano a razionalizzare l’organizzazione imponendo regole precise e incrementando le sovrastrutture di controllo. Infine, nel ʼ99 tornano a un modello più elastico e, per certi versi, perfino più “debole”, anche se la scelta di far svolgere il concerto su una base aerea impone a tutti il rispetto di alcune regole di fondo. In ognuna delle tre edizioni, Lang e i suoi pongono al centro di tutto il loro lavoro la questione della compatibilità: ciò che fanno deve risultare compatibile con l’ambiente circostante e deve saper conciliare l’appeal “ideologico” del raduno (pace, amore e musica) con le esigenze del merchandising.
G.C. Non solo. La loro abilità, mi pare, sta soprattutto nella capacità di creare una community. Di presentare l’evento-concerto come qualcosa che crea identità e rafforza la comunità. Michael Lang è straordinario per come riesce a capire i bisogni e le aspettative di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’evento. Capisce gli abitanti che temono per la loro sicurezza, capisce la voglia speculativa del proprietario del terreno che dovrà ospitare il parcheggio, capisce le esigenze di chi si occupa dei gadget e di chi vuol vendere giochini elettronici. Infine, soprattutto, ha un fiuto incredibile per cogliere le aspettative del suo pubblico potenziale e nel fare tutto il possibile per appagarle.
S.S. È senz’altro un grande organizzatore. Cioè uno che riesce a tenere assieme gli interessi e le esigenze più disparate, e a negoziare un compromesso che consenta a tutti di ricavare dall’evento un proprio vantaggio.
G.C. La sua abilità è proprio qui: far intravedere un vantaggio anche a chi sulla calta sembrava non averne. Coinvolgere tutti in un’impressione di comunità.
S.S. E farlo, per di più, anche con un pizzico di disincanto, perfino con una certa ironia. Quando si vede costretto ad aumentare le censure e i divieti, o a imporre perquisizioni per evitare che le persone si portino dietro oggetti pericolosi, Lang sorride. Come se ci dicesse: “io ci devo tentare, anche se non ci credo più di tanto ... “.
G.C. Come spieghi, sul piano comunicazionale, il fatto che Lang mantenga ancor oggi lo stesso look che aveva negli anni sessanta?
S.S. Come un ulteriore indizio del fatto che anche a distanza di trent’anni il suo modello di organizzazione si è adattato alle nuove esigenze, ma conservando lo stesso imprinting di allora. My Generation è davvero un bell’esempio di “storia organizzativa” che procede per stadi di sviluppo: da una struttura embrionale e monocentrica si passa a una struttura più complessa, basata sulla diversificazione dei ruoli e delle responsabilità.
G.C. Al di là della figura di Lang, a me il film ha fatto tornare in mente certe osservazioni di Elias Canetti sulla massa, e sull’impossibilità di comprimerla e ordinarla più di tanto in rigide strutture relazionali. C’è una carica incredibile di energia, allo stesso tempo gioiosa e rabbiosa, che scorre nelle immagini e nel montaggio di Barbara Kopple ...
S.S. Credo sia l’aspetto più appariscente del film. Ma anche quello sociologicamente più stimolante: negli anni novanta Lang e i suoi si sforzano di creare una situazione il più possibile ordinata e si vedono contestare dal pubblico proprio l’eccesso di organizzazione. Troppo rigida, burocratica, forzata. È uno dei paradossi della contemporaneità: il bisogno di organizzazione, necessaria e indispensabile per attivare i processi di ridefinizione identitaria promessi da un evento spettacolare come Woodstock, si accompagna al rifiuto dell’organizzazione stessa, vista come coercitiva della libera espressione della soggettività. È proprio tra i due poli di questo paradosso che si gioca oggi, in tutti i contesti, il tema dell’organizzazione.