Magazine archive
2025/4

Focus. The Drivers of Change in Urban Mobility
- The Drivers of Change in Urban Mobility , Zerbini Fabrizio
- From Historical Patterns to Future Trajectories. Tracing the Evolution of Gen Z’s Mobility Practices , Borghini Stefania, Colm Laura, Medici Beatrice
- Insights From a Cross-Cultural Study: Adoption of Electric Vehicle Rentals in Tourism , Gaur Aakanksha
- From Adoption Barriers to Collaborative Models: Rethinking Shared Mobility for Young Generations , Sorbino Francesco
- Charging Behaviors in Urban Centers: The Need for an Integrated EV Energy Ecosystem , Cirrincione Armando
Visual readings
Science
- Creating Value in Global Knowledge Networks. Trust as a Strategic Lever for Collaboration , Blomqvist Kirsimarja, Michailova Snejina, Snow Charles C.
- An Analysis of Stakeholder Engagement. Communicating Sustainability Through Account-Based Marketing , De Giovanni Pietro, Spahiu Esli, Spinosi Lorenzo, Vishkaei Behzad Maleki
2025/3

Focus. Strategies and Challenges in Green Marketing
- Guidelines for Sustainable Communication: Green Marketing Strategies in Video Content , Losito Cristoforo, Farace Stefania, Tuan Anna Maria, Montaguti Elisa
- Green Messaging in Italian Grocery: Communicating Sustainability Through Packaging , Branca Generoso, Shi Qiaoni, Valentini Sara
- Mobilization and Behavioral Impact: A Strategic Framework for Climate Action , Shi Qiaoni, Valentini Sara, Zhou Liyang
- Electronics and Fashion Consumption: Balancing Sustainability and Accessibility , Batelli Micol, Di Iorio Vinicio, Frey Marco, Iovino Roberta, Testa Francesco
Visual readings
Science
Themes
- Social Return On Investment: Measuring the Impact of ESG Initiatives , Bartiromo Marianna, Filangieri Lauretta, Pirro Ruggiero Antonella
- Organizational Reactions to Expert and Consumer Evaluations in Haute Cuisine , Di Stefano Giada, Favaron Saverio D.
- The Apple Paradox: When Excellence Becomes Vulnerability , Papadimitriou Thanos
2025/2

Focus. Values and Principles Redefining Controlling
- Beyond Practice Updates. Values and Principles Redefining Controlling , Dossi Andrea
- ESG and Management Control Systems: A New Paradigm for Value Measurement , Caglio Ariela
- Aligning Strategy and Indicators. Measurement Systems Driving Execution , Meloni Gianluca, Morelli Marco
- Benefits, Risks, and Future Perspectives. The Role of AI in Management Control , Dossi Andrea, Santoli Eleonora
Visual Readings
Science
2025/1

Focus. Leveraging Loyalty to Create Value
- The Strategic Power of Customer Relationships: Leveraging Loyalty to Create Value , Busacca Bruno, Bertoli Giuseppe
- Going Beyond Discounts: Loyalty Trends in Italian Retail , Acconciamessa Emanuele
- Analyzing the Concept of Loyalty: A Four-Dimensional Relationship with the Brand , Ciacci Andrea, Mantovani Alice, Branca Generoso
- Short- and Long-Term Metrics: Key Loyalty Indicators That Truly Matter , Penco Lara, Testa Ginevra
- The TCC Model: Turning Data Into Competitive Advantage , Branca Generoso, Ciacci Andrea, Katris Damien, Rubashkina Yana
Visual readings
Science
Themes
- Carried Interest: Balancing Incentives and Taxation , Ruozi Roberto
- Corporate & Investment Banking: Perceptions of GenZ and Millennials , Accettura Roberta, Pirro Ruggiero Antonella, Rossi Riccardo, Sisti Alessia Giorgia
- From States of Mind to Strategies Using the Moods Matrix , Castelli Paola Rita, Perotto Pierpaolo
2024/4

Editorial
Focus. Creating Value with Artificial Intelligence
- Creating Value with AI: Post-Digital Business Strategies , Meregalli Severino FREE
- From Theory to Practice: Critical Factors in AI Implementation , Ciacci Andrea
- The Reality Beyond the Hype: Three-Dimensional Applicability , De Rossi Leonardo Maria, Diaferia Lorenzo
- Successful Business Cases: AI Implementation Best Practices , Ciacci Andrea, Raimondi Claudio
Visual Readings
Science
2024/3

Focus. Enhancing Sustainability Throughout the Value Chain
- The Rising Adoption of GRI Standards. Enhancing Sustainability Across the Value Chain , Trindade Maria A. M., Grando Alberto FREE
- Sustainability and Business Performance. Building Resilience with GRI Practices , Maleki Vishkaei Behzad, De Giovanni Pietro FREE
- Responding to Shock Events. Time To Recovery, Indicators, and Strategic Approaches , Ruzza Daniel FREE
Science
2024/2

Editorial
Focus. Rethinking HR Strategies and Public Employee Roles
- A Forward-Looking Vision. Rethinking HR Strategies and Public Employee Roles , Valotti Giovanni
- A Strategic Imperative. The Role of HR Management in Italian PSOs , Sottoriva Claudio Buongiorno, Valotti Giovanni
- Bridging the Skills Gap. How New Competencies Drive Innovation , Vidè Francesco, Giacomelli Giorgio
- War for Talent or Trawl Fishing? Balancing HR Needs and Quality in PSOs , Lenzi Lavinia, Saporito Raffella
- Next Generation Performance Appraisals. Balancing Administrative and Development Goals , Barbieri Marta, Micacchi Marta
- The European Commission's ComPAct: Bringing Innovation to EU Public Administrations , Dotto Daniele
Visual Readings
Themes
- Embracing Expert Approaches in Modern Credit Rating Modelling , Ciampi Francesco
- Microfinance: A New Sustainable Asset Class on the Horizon? , Dallocchio Maurizio, Etro Leonardo L., Vizzaccaro Matteo, Anconetani Rachele, Colantoni Federico
- Inclusive Brand Activism. Driving Social Change Beyond Woke Washing , Acconciamessa Emanuele
- Internet of Beings. AI and Hyper Data Revolutionize Healthcare , Grillo Francesco
- At the Wheel with Gen Z. Charting the Roadmap for Future Urban Mobility , Borghini Stefania, Cirrincione Armando, Colm Laura, Gaur Aasha, Medici Beatrice, Sorbino Francesco
2024/1

Focus. Protecting the Ocean: A New Challenge
- A New Challenge for All. Protecting the Ocean for a Sustainable Planet , Pogutz Stefano, Perrini Francesco, Pachner Jan Hans Georg, Sardà Rafael, Fumagalli Federico
- Beyond Awareness. Calling Companies to Action , Manlio De Silvio Manlio, Fumagalli Federico, Daminelli Roberta, Andreoni Marta, Magni Giulio
- The Future of the Blue Economy. From Risk Mitigation to Business Opportunities , Cozzi Ambra, Galvani Laura, Biggi Livia, Theodorou Nikolaos Alexandros, Strina Maria Giulia
- The Ocean Disclosure Initiative. A New Platform for Collective Change , Pogutz Stefano, Perrini Francesco, De Silvio Manlio, Pachner Jan Hans Georg, Magni Giulio, Fumagalli Federico, Cozzi Ambra
Visual Readings
Themes
- Capital Markets. A Key Asset for Growth , Caselli Stefano
- Ethical Challenges of Artificial Intelligence , Vicari Salvatore
- Key Factors for Managing AI in Business , Sciarelli Sergio
- A Learning Orientation to Improve Impact Across Sectors , Beech Nic, Hibbert Paul, Mason Katy
- European Management Model: A Reality or a Chimera? , Zattoni Alessandro
- The Need to Transform Marketing Practices , Busacca Bruno, Bertoli Giuseppe
- Hearing Aid Industry. The Hi-Tech Human Side , Fornari Valentina
- The Corporate Debt Alarm. What’s Next , Ruozi Roberto
2023/4

Editorial
Dossier. Driving in the Future
- The Great Challenges for Italian Industry , Zirpoli Francesco
- A Great Future Behind Us? , Perugini Mario
- The Keyword is Transformation
- Public Policies for Recovery , De Palma Michele
- Expected and Real Benefits of Industry 4.0 , Calabrese Giuseppe Giulio
- Transition to Electric: the Risks for Employment , Bubbico Davide
- Sustainable Mobility Between Obligation and Aspiration , Colm Laura
Focus. Driving in the Future
Focus. Agribusiness Searching for a Future
- All the Ingredients of Supply Chain Resilience , Lo Zoppo Marianna, Amico Biagio Maria
- Sustainability Benefits All Actors, Including Financial Interests , Fiorillo Vitaliano, Amico Biagio Maria, Bottacin Leonardo
- Vertical Farming: from Hype to Disinvestment , Giannetti Federico, Lo Zoppo Marianna
- Collaborating is Difficult, but for Supply Chains it is Necessary , Saputo Aristea
Focus. The Future of Sports between Value and Values
- A Model of Sports Between Olympic Spirit and (Hyper) Professionalism , Ruta Dino
- Milan’s Olympic Ambitions Reach New Heights , Billari Francesco C.
- Athletes and Careers: The Game Is Played Off the Field Too , Ruta Dino, Antonelli Luca
- An (In)Tangible Legacy: What Remains of Sporting Events , Bigotto Chiara, Palmieri Antonio
- Why Sports Facilities Are a Winning Business (for Everyone) , Ruta Dino, Palmieri Antonio
- Beyond Victory: Fan Engagement Between Identity and Community , Antonelli Luca, Raccagni Deborah
Artificial Intelligence
2023/3
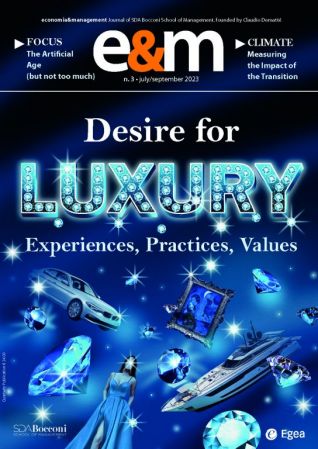
Dossier. Desire for Luxury: Experiences, Practices, Values
- Luxury Experience as a Modus Vivendi , Calefato Patrizia
- A Growing Market Despite Uncertainties , D’Arpizio Claudia, Levato Federica
- Global Players are Shopping for Smaller Businesses , Baro Jessica, Dallocchio Maurizio, Etro Leonardo
- Discretion and Refinement at the Core of Quiet Luxury , Carraro Stefania, Misani Nicola
- Excellence Becomes a Group: the Case of Florence , Lojacono Gabriella
- NFTs for a New Customer Relationship , Pan Laura Ru Yun
- Authenticity Generates Uniqueness, Trust, and Loyalty , Lojacono Gabriella
- Personalizing the Product, but with Moderation , Prandelli Emanuela
- Luxury Hospitality: Challenges, Trends, and Good Practices , Kim Sowon, Girardin Florent, Fuchs Matthias
- The Growth of Fine Dining: the Case of Langosteria , Lanza Pietro
- Jewelry between Continuity and Transformation , Vigneron Cyrille
Focus. The Artificial Era (but not too much)
- Looking Closely Through the Digital Mirror , Castelli Gianluigi, Meregalli Severino
- Cybersecurity and Companies: If the Worst Virus is the Mentality , Abbatemarco Nico
- Possible Metaverses: Archetypes and Use Cases to Go Beyond the Hype , De Rossi Leonardo M., Salviotti Gianluca
- Here Is the Pen, ChatGPT! Generative AI Put to the Test with Text , Diaferia Lorenzo
Public Administration
2023/2
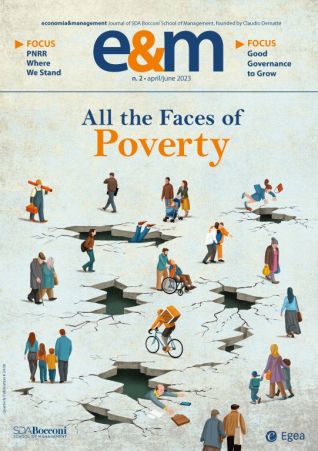
Editorial
DOSSIER. All the Faces of Poverty
- The Entirely Italian “Poverty Regime” , Saraceno Chiara
- Disadvantaged Stories as Inheritance , De Lauso Federica
- Youth and Work: A Crucial Issue , Bertolini Sonia, Borgna Camilla, Romanò Sara
- Educational Poverty Requires Strong Choices , Curti Sabina
- Rethinking Italy’s Citizens’ Income , Lenzi Antonio
- More Light in the World of the Homeless , Cortese Caterina
- Give Us This Day Our Daily Bread , Perretti Fabrizio, Simonella Zenia
FOCUS 1. Do All Roads Lead to the PNRR?
- The Territorial Allocation of Resources, between Good and Bad , Altomonte Carlo, Biasioni Francesco, Gottardo Giulio
- Investments Require New Leadership in the Public Sector , Vecchi Veronica, Cusumano Niccolò, Motta Lorenzo, Saporito Raffaella
- Simplifying to Grow and Win the Race Against Time , Micacchi Lorenza, Lenzi Lavinia, Valotti Giovanni
- The Challenge for Towns and Cities is to Invest in Real Projects , Nicotra Veronica
FOCUS 2. Good Governance Produces Growth (in Multiple Directions)
- Positive Effects on Performance, Both Direct and Indirect , Minichilli Alessandro, Montemerlo Daniela, D’Angelo Valentino, Bastos Castilho Joao Pedro, Di Francesco Manuel, Di Caprio Giovanni
- Compliance Issues are Relevant Factors for Strategic Decision-Making , Acerbis Fabrizio
- The Epochal Challenges of the 2020s: Financial Intermediation , Ragaini Andrea, Albonico Marzio
- Growing to Preserve Italian Excellences: The Role of Investors , Paoli Tommaso
Sustainability
Digital Sustainability
Innovation and Marketing
2023/1

Dossier. China: So Close Yet So Far
- The Internationalization of the Chinese Currency , Amighini Alessia FREE
- The Magic Circle of Xi Jinping , Attanasio Ghezzi Cecilia
- The US Strategy to Contain Beijing , Pugliese Giulio
- Risks and Opportunities for Italian Businesses , Zadro Alessandro
- The New Silk Road. One, None and a Hundred Thousand , Franceschini Ivan FREE
- Multicultural Leadership as a Lever for Success , Zhou Fei Francesco
- Doing Business in China: The Case of Brembo , Simonelli Silva Umberto
- Internet Meets the Great Wall , Negro Gianluigi
- The Myth of Guanxi: What We Really Know , Opper Sonja
- Management Faces the Untranslatable , Pontiggia Andrea, Morbiato Anna
Focus. Small and Medium Enterprises: Challenges for the Future
- SMEs and Continuity of Success in the New Scenarios of Competition , Tripodi Carmine FREE
- A Complex Three Years that Bring Problems and Opportunities , Puricelli Marina
- Facing the New Normal: Skills, Resources, and Leadership , Visconti Federico, Lazzarotti Valentina
- The Four Strategies to Promote Sustainable Practices , Perrini Francesco, Pogutz Stefano, De Silvio Manlio
- Diversity Management: An Extensive Terrain Still to Be Explored , Basaglia Stefano
Mergers & Acquisitions
Internationalization
Administration & Control
Organization & People Management
2022/4
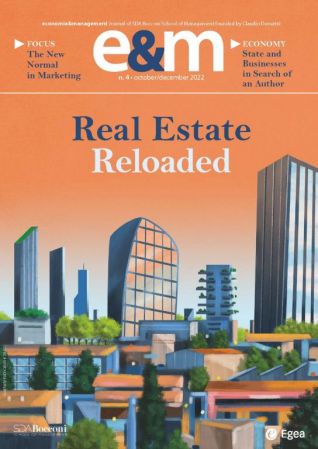
Dossier. Urban Regeneration
- The Virtuous Circle of Sustainability , Bezzecchi Alessia FREE
- Opportunities in Urban Regeneration , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Abbadessa Mario, Albertini Petroni Davide, Della Posta Giovanna , Ruckstuhl Andrea
- Green Finance and Sustainable Regeneration , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Coticoni Stephen, Serrini Riccardo, Tedesi Luca, Turri Lia
Dossier. Living
- New Social Needs at the Center of Living , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia
- Make Way for Proptech as a Lever for Growth , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Cominelli Barbara, Grillo Marco
- New Housing Needs and Market Responses , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Adduci Pietro, De Albertis Regina
- The New Logics of Territorial Readjustment , Beltratti Andrea, Bezzecchi Alessia, Mazzanti Alessandro, Ricciardi Paola
Dossier. Commercial
- Great Transformations of the Sales Sector , Morri Giacomo, Benedetto Paolo FREE
- Offices Are Changing; Investments, Too , Morri Giacomo, Benedetto Paolo, Al Salhi Muhannad, Catella Manfredi, Dal Pastro Alexei
- The Customer Experience as the Heart of Hospitality , Morri Giacomo, Basterrechea Chema, Keller Stefano, Schiavo Giampiero
- Retail and Logistics: Two Sides of the Same Coin , Morri Giacomo, Sandberg Joachim, Véron Eric
Focus. The New Normal in Marketing
- The New Normal in Marketing , Castaldo Sandro, Zerbini Fabrizio
- When Images Become a Repository of Data for Businesses , Cillo Paola, Grossetti Francesco, Rubera Gaia
- Brand Management between Back to the Future and Interstellar , Busacca Bruno, Ostilli Maria Carmela
- The Key Points of the Digital Transformation of Go-to-market , Castaldo Sandro, Zerbini Fabrizio
- Ten Areas of Action to Redesign the Sales Function , Caiozzo Paola, Colm Laura Ingrid Maria, Guenzi Paolo, Aurelio Sisti Marco
Visual readings
Economic policy
Organization and People Management
2022/3
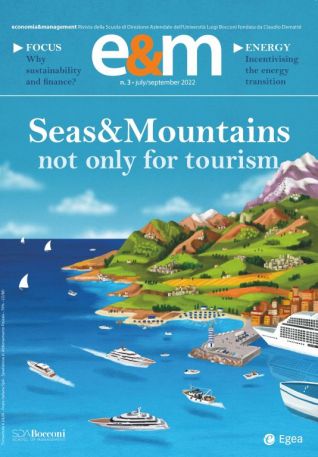
Dossier. Seas&Mountains
- New Trends in Beach Tourism , Antonioli Magda, Bricchi Sara FREE
- Technology and Sustainability Take a Cruise , Pellegrino Domenico FREE
- Tradition and Innovation for Luxury Boating , Saviolo Stefania
- Threats and Opportunities for the Fishing Industry , Sabatella Evelina Carmen
- Mountain Tourism in Transition , Mottironi Cristina
- New Inhabitants in Mountain Territories , Corrado Federica
- The City Needs the Mountains , Golino Antonella
- The Great Challenge of Milan-Cortina , Antonioli Magda
Visual readings
Focus. Sustainable Finance
- Sustainable Finance. Why It Has to Change , Dallocchio Maurizio FREE
- ESG Rating and Credit: How to Assess Integrated Risk , Calcaterra Michele
- The Impact of Sustainability on the Cost of Capital , Caragnano Alessandra
- Accelerating the Transition: Financial Services Must Also Do Their Part , Marchesi Cecilia
- The Creation of Value through Sustainable Debt Instruments , Pippo Federico, Talamini Andrea
- Social Responsibility, Environmental Sustainability, and ESG Ratings in Italian SMEs , Lanza Andrea, Roscio Anna Maria
Environmental Economics
Extraordinary finance
Economy, work and organisations
2022/2

Dossier. Check-up on Healthcare
Dossier. Lessons from the Covid-19 era
- The Four Eras of the SSN in Two Years , Longo Francesco
- Destination Value in Healthcare , Lecci Francesca, Foresti Luca
- Operations management as a Critical Factor , Fenech Lorenzo
- The Great Challenge of Personnel , Montanelli Roberta, Sartirana Marco
- General Directors Face the Crisis , Del Vecchio Mario, Romiti Anna
- The Contribution of Private Operators , Preti Luigi Maria, Ricci Alberto
Dossier. Research & Services
- How the Supply Chain Has Changed , Borgonovi Elio, Ripa Di Meana Francesco
- Digitalization: Certainties and Opportunities , Boscolo Paola Roberta, Tarricone Rosanna
- The Impact of the PNRR on Care , Tozzi Valeria, Casati Giorgio
- Innovation Wanted for Seniors , Notarnicola Elisabetta, Perobelli Eleonora, Rotolo Andrea
- Generating value with purchases and investments , Vecchi Veronica, Cusumano Niccolò, Tanese Angelo
Visual Readings
Focus. All the Value of the Space economy
Focus. Space Economy
- The importance of the public-private relationship , Iacomino Clelia, Pianorsi Mattia, Saputo Aristea
- Why and how to reduce the large amount of space debris , Iacomino Clelia, Pianorsi Mattia, Saputo Aristea
- To the Moon for Interplanetary Exploration? , Iacomino Clelia, Pianorsi Mattia, Saputo Aristea
Strategy and enterprise
Project Management
Organization and People Management
2022/1
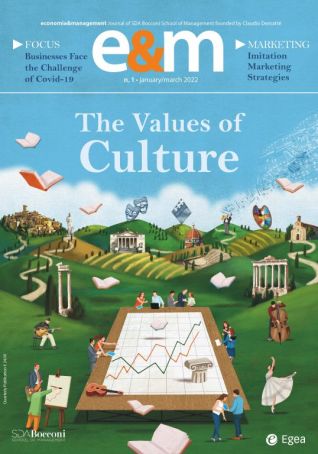
Dossier. Introduction
Dossier. Innovation & Tradition
- Strength and Fragility of Reading , Dubini Paola
- The Proximity of Libraries , Faggiolani Chiara [*]
- The Digital Transition of Museums , Guerzoni Guido FREE
- Innovation Strategies for Museum Collections , Monti Alberto [*]
- New Experiences of Consumption The Case of the FAI , Rurale Andrea, Carù Antonella, Dalle Carbonare Piergiacomo Mion [*]
- The Impact of NFTs on the Art World , Pola Francesca
Dossier. The 2030 Agenda and Local Territories
- Cultural Welfare Beyond Experimentation , Cicerchia Annalisa *
- Capitals of Culture: Experimenting with the Future , Baia Curioni Stefano, Morganti Ilaria
- Corporate Collections and Business Performance , Paolino Chiara
- Digital Nomadism as an Opportunity for Tourism , di Salle Marianna, Mottironi Cristina
- The Regeneration of the Venetian Lazarettos , Fazzini Giorgia
- Multiculturalism, Diversity, and Inclusion Strategies , Lucchetti Marco, Turrini Alex [*]
Focus. Introduction
Focus. Businesses Face the Challenge of Covid-19
Digital marketing
Organization and People Management
Economic sociology
2021/4
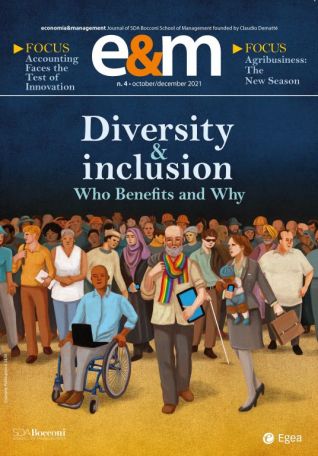
Editorial
Dossier. Scenarios and Challenges
Dossier. Business, Society, and Law
- Gender Pay Gap: The Role of Businesses , Casarico Alessandra FREE
- Women and the PA: A Case of Half Success , Saporito Raffaella, Rota Silvia, Trinchero Elisabetta FREE
- What Future for Gender Budgeting? , Galizzi Giovanna
- What Unions Can and Must Do , Pulcher Simone
- Managing Disability Beyond the Stigma , Cuomo Simona, Simonella Zenia
- It’s Decision Time on Migrants , Monaci Massimiliano
- The Body of Law Against Discrimination , Lorenzetti Anna
Visual readings
Focus. Accounting
Focus. Agribusiness
- The New Season of Agribusiness
- The Entire Supply Chain Faces the test of Innovation , Lo Zoppo Marianna, Saputo Aristea
- The New Rules on European and Italian Agricultural Policy , Mastrandrea Francesco
- The Growth of Vertical Farming Between Reality and Promises , Lo Zoppo Marianna, Fiorillo Vitaliano
People management
2021/3
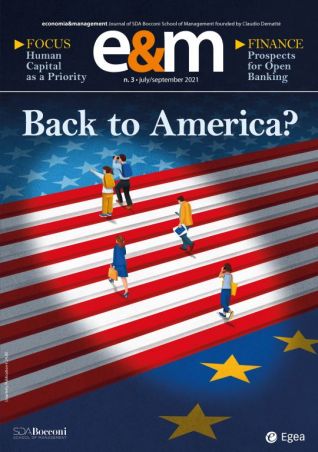
Dossier. Geopolitics
Dossier. Businesses and managerial models
- Digital platforms: an (almost) all-out battle , Colangelo Giuseppe FREE
- Trade Opportunities and Possible Perils , Miranda Lucio
- The New Overseas Route for Italian Fashion , Marafioti Elisabetta
- Successful strategies for the agri-food industry , Veronesi Vittoria, Pirotti Guia Beatrice, De Angelis Corvi Elena FREE
Focus. Political economy
Visual Readings
The Debate. State vs. Market
Organizational behavior
Strategy and entrepreneurship
Strategic management
Innovation & Operations Management
2021/2
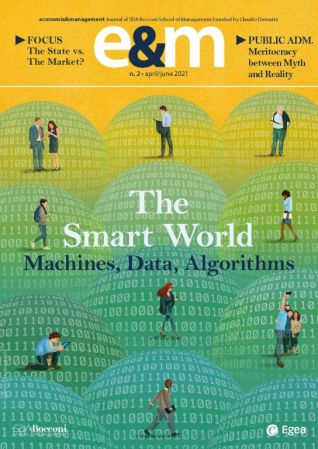
Dossier. The Context
- What’s Behind Artificial Intelligence? , Diaferia Lorenzo, Salviotti Gianluca FREE
- How to Create Value with the Data Economy , Cillo Paola, Rubera Gaia FREE
- Innovation and Algorithms, To Be Managed with Care , Corrocher Nicoletta, Guerzoni Marco, Nuccio Massimiliano Nuccio
- The Reason of Optimism in Italy , da Empoli Stefano
Dossier. Management&Application
- Advanced Analytics for Managerial Decision , Borgonovo Emanuele, Molteni Luca FREE
- Challenges and Solutions for the Banking Sector , Omarini Anna
- Skills, Ethics, and Safety in the Service of Health , Ciani Oriana
- The Benefits of Algorithms in Business Organization , Pedronetto Paolo
- Data Scientists: Who They Are, What They Do, and How They Do It , Molteni Luca, Poli Maurizio
Focus. The State vs. The Market?
Visual readings
Corporate finance
Public Administration
Business Strategy
Strategy & Entrepreneurship
2021/1
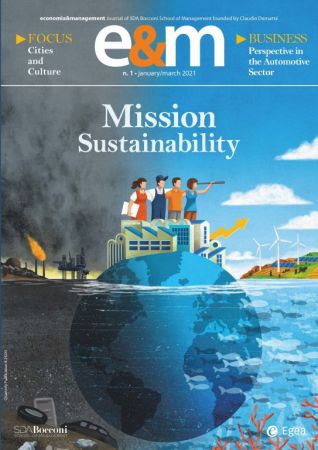
Dossier. Introduction
Dossier. Business and Global Scenarios
- The 2030 Agenda: An Appointment that Regards Us All , Giovannini Enrico, Perrini Francesco, Pogutz Stefano, Casati Paola FREE
- The Centrality of Corporate Governance , Minichilli Alessandro, Perrini Francesco, Casati Paola
- ESG Ratings: Love Them or Hate Them? , Perrini Francesco, Iantosca Anna
- From Competition to Collaboration , Tencaci Antonio
- Why and How to Be a B Corp or Benefit Corporation , Misani Nicola
- When a Trademark Transforms the Value Chain , Morici Giuseppe, Pogutz Stefano FREE
Dossier. Alternative Perspectives
- Decarbonization and the Challenges of Big Oil , Di Castelnuovo Matteo, Biancardi Andrea
- All the Potential of the Blue Economy , Pogutz Stefano, De Silvio Manlio, Fumagalli Federico, Pachner Jan, Magni Giulio
- Sustainability Leaders for the Preservation of the Oceans , Allevi Virginia, Saputo Aristea, Rizzi Giorgia, Daminelli Roberta
Focus. Introduction
Focus. Cities and culture
Visual reading
Public administration
People management
2020/5
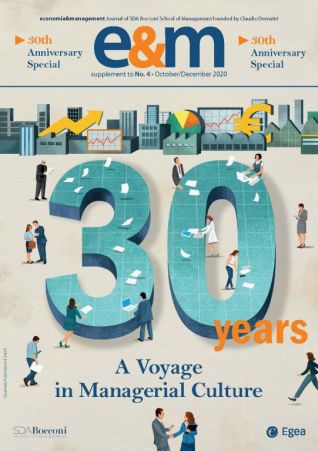
- Special: 30 Years of Economia&Management
- The Strength of Roots to Anticipate the Future , Soda Giuseppe
- 1988-1997: The Debate on Business Models , Basaglia Stefano, Simonella Zenia
- 1998-2007: Great Transformations at the Turn of the Millennium , Basaglia Stefano, Simonella Zenia
- 2008-2018: How to Interpret the Post-crisis Period , Simonella Zenia, Basaglia Stefano
- Looking Back over the Magazine’s First Thirty Years , Basaglia Stefano, Simonella Zenia
- Corporate Governance: between Art and Profession , Dematté Claudio
- Knowledge: A Factor for Competitiveness , Corbetta Guido
- Being Interesting, Rigorously , Perrone Vincenzo
- Expanding the Horizon without Prejudice , Perretti Fabrizio
2020/4
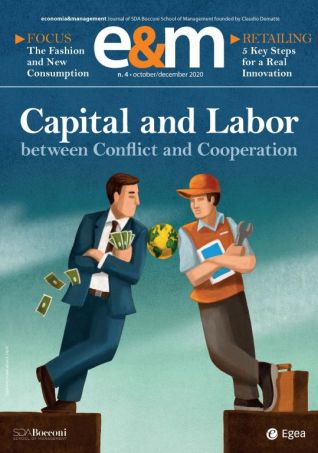
Dossier. Rethinking Globalization
- State Intervention in the Economy? What Counts is Quality , Zamagni Vera
- A New Management of Global Markets , Calabrò Antonio
- Why We Should Go Back to Reading Marx , Bellofiore Riccardo, Vertova Giovanna
- Industrial Relations in the Time of Globalization , Pedersini Roberto
- Aggregate Demand is the Italian Problem , Perugini Mario
Dossier. Who Represents What
- All of the Doubts and Challenges within Confindustria , Berta Giuseppe
- Business-Labor: Equal Status and Common Planning , Perretti Fabrizio FREE
- Four Possible Destinies for Labor Unions , Reyneri Emilio
- How and Why Solitude is Growing among Insecure Workers , Colella Francesca
- A New Model of Co-Responsibility , Del Chicca Andrea, Mancini Alessandro
Visual Reaadings
Focus. The Fashion Industry and New Consumption
Innovation & Operations Management
Sharing Economy
Digital Procurement
Insittutions and Society
2020/3
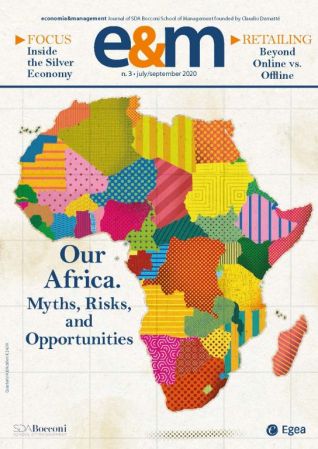
Dossier. Economic-political developments
Dossier. Society and the environment
Dossier. Business and company
Visual Readings
Focus. Silver economy
- How the Demographic Profile Has Changed , Salaris Luisa
- Age Management A Necessary Choice , Gravaglia Emma
- Old Age as Stimulus for a New Form of Welfare , Berloto Sara, Longo Francesco, Notarnicola Elisabetta, Perobelli Eleonora, Rotolo Andrea
- The Long-Living, or Ageless, Consumer , Palmarini Nicola
- Large-scale retailers Aim to Conquer the Silver Customer , Buccoliero Luca, Bellio Elena
Accounting and financial statements
Mergers & Acquisitions
Public administration
2020/2
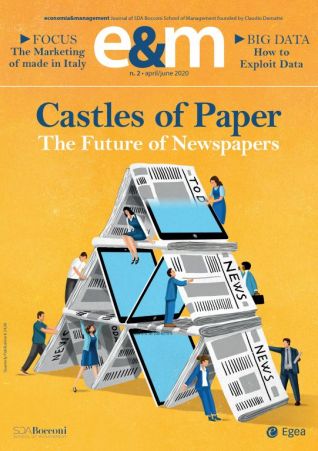
Dossier. The Scenario
Dossier. The Information Industry
Dossier. The Media Diet
Visual Readings
Focus. Marketing Made in Italy Products
- What It Means to Talk about Made in Italy , Costabile Michele
- Cultural Specificity and Quality of Production , Ancarani Fabio, Costabile Michele, Mazzù Marco Francesco
- How and Why to Defend our Coolness , Costabile Michele, Fei Carlo, Mazzù Marco Francesco
- The Supply and Demand of Uniqueness , Costabile Michele, Mazzù Marco Francesco
Digital transformation
Organization
Financial Systems
2020/1
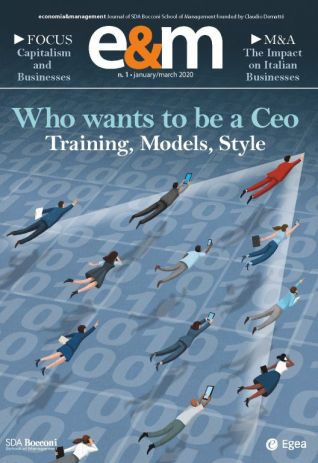
Editorial
Dossier. Training
Dossier. Models
Dossier. Challenges
Dossier. Corporate governance
Visual readings
Focus. Capitalism and Business
Public management
Compensation
Special 30 Years of Economia & Management
2019/4
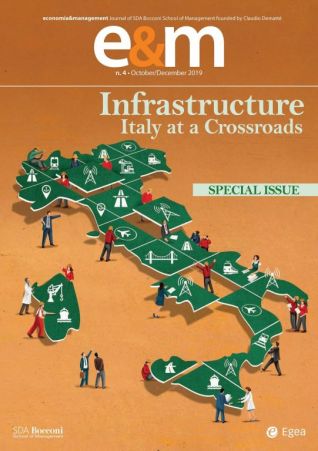
Editorial
Dossier. Infrastructure, Italy at a Crossroads
Dossier. Infrastructure, Italy at a Crossroads: Transports
Dossier. Infrastructure, Italy at a Crossroads: Networks
- The Digital Future of the Italian System
- 5G: Infrastructure Seeking an Author
- Digitalizing is a Must
- New Rules for the Infrastructure of the Gigabit Society
- The Open Fiber Project: how and why
- Networks at the Center of the Urban Ecosystem
- Electric Infrastructure for tomorrow
- Electric transition between the present and the future
Dossier. Infrastructure, Italy at a Crossroads: Territories
Visual readings
2019/3
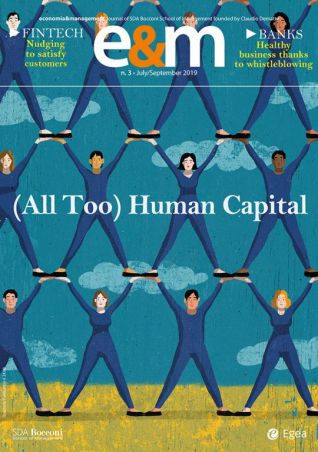
Dossier: (all too) human capital
Dossier: The Scenario
Dossier: Recruiting and Selection
Dossier: Careers
Dossier: Institutions and Representation
Visual Readings
Financial Services
Special 30 Years of Economia & Management
2019/2
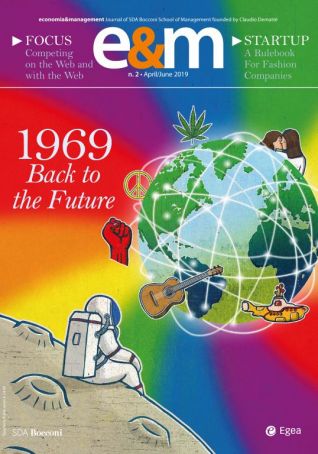
 2025/4
2025/4